Con Phoenix che non giungeva all’ultimo atto dal 1993, e Milwaukee che attende il titolo da cinquant’anni (prima di oggi, le Finals le avevano giocate nel 1971 e nel 1974), la domanda sorge spontanea: si tratta delle finali NBA più sorprendenti di sempre?
Considerando il percorso imprevedibile dei superteam falcidiati dagli infortuni, ed i treni storici passati da tempi immemori, indubbiamente ci troviamo davanti ad un’edizione difficile da pronosticare ad inizio delle ostilità.
Difficile ma non impossibile, è bene sottolinearlo. Perché se i Bucks erano reduci da anni di delusioni con la sensazione che mancasse poco a completare il percorso, i Suns rappresentano la squadra più continua della stagione in materia di qualità di gioco e risultati, a partire dalla prima gara di regular season.
Per il gruppo guidato da coach Budenholzer, le aggiunte di Holiday prima e Pj Tucker poi, regalavano tutto ciò che era mancato nei campionati trascorsi, almeno sulla carta. Dall’altra parte, una squadra capace di impressionare con otto vittorie e zero sconfitte nella bolla di Orlando – esclusa dal play-in per un soffio – ha colto l’occasione di inserire un futuro Hall of Famer come Chris Paul, e la duttilità del mastino Jae Crowder, per garantirsi l’esperienza necessaria a far maturare un roster giovane, di bellissime speranze, ma che stanziava nei bassifondi della lega da troppi anni.
Detto questo, per capire quanto interessante sia la serie che stiamo seguendo, anche in relazione al passato, è necessario provare a quantificare il significato del termine “sorprendente”. Almeno in questo campo di azione. Perché nella storia della lega abbiamo avuto finali impreviste, senza squadre di blasone comunque poco quotate ai blocchi di partenza, oppure vincenti inaspettate, o ancora finaliste arrese all’ultimo chilometro. Ma ugualmente imprevedibili.
È tempo quindi di fare un piccolo riassunto, utile a scoprire che per quanto l’upset sia all’ordine del giorno nella lega, raramente le grandissime squadre hanno steccato nelle stagioni in cui erano più attese.
Le Finals che non ti aspetti
Partiamo dal presupposto che tutto ciò che accade nella NBA prima degli anni ‘60, è per noi invalutabile. Si tratta di epoche difficili da immaginare, ovviamente poco testimoniate da immagini e video, oltre che da cronache oggettive.
Il decennio a seguire invece, si svolge sotto il dominio dei Boston Celtics con nove titoli e dieci apparizioni alle Finals dal 1960 al 1969, principalmente contro i rivali storici dei Los Angeles Lakers (con qualche incursione dei St.Louis Hawks e dei Philadelphia 76ers).
Negli anni’70, il primo vero scontro che non presenta due squadre “blasonate”, lo troviamo nel 1978. Da una parte i Washington Bullets, che comunque si erano già fatti vedere ad altissimi livelli grazie alla coppia formata da Wes Unseld e Elvin Hayes. Dall’altra dei Seattle Supersonics difficili da pronosticare, tra l’altro protagonisti di una stagione non certo strepitosa per risultati.
Iniziata in modo pessimo sotto la guida di coach Bob Hopkins (con un record di 5-17), per richiamare in panchina l’ex stella Lenny Wilkens, già provatosi nella Città di Smeraldo come allenatore/giocatore.
Il risultato è l’immediata promozione in quintetto di Jack Sikma, Dennis Johnson e Gus Williams, che rappresentano il nucleo che avrebbe vinto l’unico titolo nella storia della franchigia, l’anno seguente.
Nel 1978 le cose si accomodano raggiungendo 47 vittorie stagionali, pur generando il malcontento di Slick Watts, beniamino del pubblico che chiede la cessione ottenendo soddisfazione, e finendo così ai New Orleans Jazz. Al primo turno superano clamorosamente i Lakers di Kareem, Norm Nixon, Jamaal Wilkes ed un giovane Adrian Dantley, ed al secondo affrontano i campioni in carica di Portland, guidati da Bill Walton.
Anche qui, con il pronostico sfavorevole, grazie alla complicità di un Walton claudicante i Sonics vanno avanti, chiudendo la serie in sei partite e preparandosi ad affrontare i Denver Nuggets alle Conference Finals.
Con Dennis Johnson che annulla difensivamente David Thompson, il solo Dan Issell non basta per piegare la marcia trionfale di Sikma e compagni: si va alle Finals, e dopo cinque sfide si trovano in vantaggio per tre vittorie contro due, ed il potenziale spareggio in casa.
Gara sei è però un bagno di sangue, con Washington che la domina per 117 a 82, e tutto sembra saltare in aria. Sicuramente il morale dei ragazzi di Wilkens, che forse increduli per un traguardo ad un passo – o più facilmente allo stremo delle forze – non riescono a riordinare i cocci per la partita decisiva, anche se giocata tra le mura amiche.
Pur coscienti di essere ai limiti dell’imbattibile in casa, e con tanti ex giocatori presenti a palazzo come il buon Watts, tutto va di nuovo storto. Dennis Johnson chiude la partita con 0 su 14 dal campo, e rappresenta l’emblema di una squadra contratta, sprecona, incapace di reagire se non nell’ultima frazione, quando ormai è troppo tardi. Unseld gioca una partita mostruosa per solidità, e malgrado non riporti medie indimenticabili, vince il premio di MVP delle Finals.
Washington riesce a stupire il mondo rientrando ad un passo dal baratro, completando una rimonta pazzesca in una serie che li vedeva rincorrere gli avversari da subito, grazie ad un clamoroso colpo di coda.
Certo, i Bullets (ancora a Baltimore, prima del trasferimento nella Capitale) avevano già raggiunto una finale definibile sorprendente nel 1971, uscendo sconfitti con dei Milwaukee Bucks giovanissimi per fondazione, ma ne abbiamo recentemente parlato nell’articolo dedicato alla franchigia del Wisconsin. Ed ulteriormente il loro ritorno a giocarsi l’anello del 1975 non appare da meno sulla carta, ancora sconfitti e stavolta contro i Golden State Warriors di Rick Barry. Primo ed unico titolo, almeno fino all’evento della doratissima epoca recente con coach Kerr, gli Splash Brothers e compagnia.
Per incontrare qualcos’altro di veramente imprevisto, dobbiamo far un salto avanti davvero lungo stavolta, fino al 1998/99. Si tratta della famigerata “stagione con l’asterisco”, quella del primo lockout e del campionato dimezzato, in una lega orfana dei Bulls di Jordan dopo il secondo ritiro di quest’ultimo.
Le Finals se le giocano i San Antonio Spurs ed i New York Knicks, con i ragazzi guidati da un Popovich (si diceva) ad un passo dall’esonero, presentano la coppia di Twin Towers formata da giovane Duncan ed un David Robinson post infortunio, ma non un roster irresistibile.
Certo in stagione regolare funzionano bene, ma non è una novità. Tutti attendono il ritorno degli Utah Jazz, a maggior ragione con un Malone MVP stagionale, ma le due squadre non si incrociano nemmeno in una postseason bizzarra, dove Stockton e compagni soffrono decisamente l’età avanzata del roster, o quantomeno degli elementi decisivi.
Passando dal “Memorial Day Miracle” di Sean Elliott, arrivano a giocarsi il titolo da favoriti, perché dall’altra parte ci sono i Knickerbockers di Jeff Van Gundy, che in teoria sarebbero fuori dal bracket a poche gare da disputarsi.
Si qualificano da ottava vincendo sei delle ultimo 8 partite, e immediatamente battagliano contro i favoriti Miami Heat, eliminandoli con un tiro quasi allo scadere di Alan Houston nella decisiva gara cinque.
Poi è il turno di un secco sweep agli Atlanta Hawks di Dikembe Mutombo, prima di scrivere un nuovo capitolo della rivalità con gli Indiana Pacers. Il vecchio Patrick Ewing è eroico, ma si lacera il tendine d’Achille ed è costretto a gettare la spugna ad inizio serie, ma un gioco da quattro punti di Larry Johnson in gara tre regala l’inerzia decisiva a quelli della Grande Mela, che raggiungono così la finale.
Impossibile senza Pat riuscire a piegare gli Spurs, con Camby ed un improbabile Chris Dudley costretti agli straordinario, ed un eroico Latrell Sprewell non sufficiente per forzare qualcosa di più che cinque partite, al termine delle quali il titolo finisce all’ombra dell’Alamo per la prima volta. Con un improbabile Avery Johnson a decidere i momenti decisivi, con un jumper dall’angolo.
Occhio in ogni caso ai New York Knicks. Per quanto tra i favoriti in un campionato senza una reale squadra al di sopra delle altre per plebiscito, la run playoff che nel 1994 li porta ad affrontare gli Houston Rockets non appare scontata. Tanto meno lo è una finale vissuta ai tempi come “deludente” per ascolti e spettacolarità, in una lega che per la prima volta senza Jordan sembrava “perdere appeal”.
In realtà si tratta del coronamento di una stagione tra le più incerte di sempre, decisa da una postseason fatta di upset e scontri combattuti all’ultimo sangue, spesso decisi da buzzer beater unici. Quello scontro, spigoloso e deciso dalle difese per quanto riassumibile in un “Patrick Ewing contro Hakeem Olajuwon”, non solo finisce in sette partite, ma merita una rilettura a distanza di tempo. Perché tanto sorprendente quanto divertente, sotto molti punti di vista.
Anelli non pronosticabili
Ad essere onesti, vuoi per il dualismo tra Magic e Bird, vuoi per l’avvento dell’epoca Jordan dopo l’intramezzo dei Bad Boys, per attendere successi davvero impronosticabili dobbiamo giungere molto vicini ai giorni nostri. Tralasciando giusto i Pistons di Larry Brown, capaci di spazzar via il quotatissimo superteam dei Lakers con Payton e Malone ad aggiungersi a Shaq e Kobe. Un gruppo che comunque imbarcava acqua di brutto, dietro l’apparente indistruttibilità dei nomi che lo componeva.
Arriviamo così velocemente al 2010/11, altra stagione mutilata dallo sciopero, caratterizzata però dall’evento mediatico di The Decision. Quando LeBron James decide di unirsi a Dwyane Wade e Chris Bosh in quel di Miami, per formare quei BIG3 che nessuno poteva sperare di arginare, in teoria. La verità è che le aspettative eccessive, oltre ad una chimica non esattamente perfetta da costruirsi comunque in fretta e furia, permisero l’inserimento nell’albo d’oro della lega di una squadra inedita, ancora destinata a restar tale. I Dallas Mavericks di Mark Cuban.
Con Rick Carlisle in panchina ed uno stratosferico Dirk Nowitzki in campo, i Mavs si rivelano squadra ostica per chiunque, condotti dal trentasettenne Jason Kidd ed una serie di ottimi giocatori a supporto. Dopo aver sofferto il primo turno con Portland, superano agilmente Lakers e Thunder, per trovarsi proiettati nell’apparente ruolo di sparring partner per LeBron ed i suoi compagni.
Ma tralasciando il tedesco che sarà meritatissimo MVP delle Finals, se disponi di giocatori del calibro di Shawn Marion e Tyson Chandler, con innesti dalla panchina che rispondono al nome di Jason Terry e del granitico (e compatto) JJ Barea, puoi sperare di confrontarti con chiunque. Addirittura ribaltare una serie che inizia in svantaggio, e che si presenta alla quarta partita con Miami che conduce per due a uno.
Da lì in poi è una lezione continua da parte dei Mavericks, che vincono per tre volte consecutive alzando un clamoroso Larry O’Brien Trophy, che getta momentanee e pesanti ombre sul progetto BIG3 di Miami, e soprattutto sulla capacità di James di guidare una squadra al successo. Una roba destinata a cambiare di lì a poco, ma ridondante fino ad allora, sostenuta da un successo per certi versi unico nel suo genere.
Nel 2019 invece, a proposito di inediti appare l’unica franchigia titolata a non trovarsi in suolo statunitense. Unica in corsa, peraltro. Il percorso dei Toronto Raptors non può che definirsi sorprendente, sia per come giungono alle Finals che per l’avversario sconfitto. Quei Golden State Warriors che al quartetto formato da Curry, Thompson, Green e Durant aggiungono in offseason anche Demarcus Cousins. Già una scommessa a causa degli infortuni sofferti, ma ancora molto valutato rispetto all’oggi. E non potrebbe essere altrimenti considerando le ulteriori disgrazie che ne hanno interrotto il percorso a seguire.
Eppure ai tempi si parlava di “squadra che uccideva la competizione”, mentre Toronto poteva fregiarsi di aver scambiato DeMar Derozan con San Antonio per Kawhi Leonard. Un giocatore spedito al freddo canadese quasi per punizione, dichiaratamente deciso a scappar via veloce nella ventura finestra di free agency che lo avrebbe visto protagonista. Ma le cose cambiano con la Trade Deadline.
Cj Miles, Jonas Valančiūnas, Delon Wright ed i diritti di una scelta al secondo giro del 2024 vengono spediti a Memphis, in cambio di Marc Gasol. E l’idea sembra proprio quella di provarci, sfruttando l’occasione di un singolo campionato con un gruppo profondo, con autentiche soprese come Pascal Siakam e Fred VanVleet, in rapida ascesa.
Dopo una clamorosa sconfitta alla gara d’esordio in postseason con Orlando, il primo turno passa in modo relativamente tranquillo. Ma l’idea che si tratti di una squadra predestinata si manifesta nelle semifinali di Conference contro i Sixers di Embiid, che forzano una gara sette dal finale incredibile. Gli ultimi punti dei 41 messi a referto da Kawhi Leonard ballano sul ferro ben oltre il suono della sirena conclusiva: se la palla esce si va ai supplementari, se entra è uno dei tiri più sofferti di sempre.
Il segnale è inequivocabile. Alle Conference Finals perdono le prime due gare a Milwaukee, prima di vincerne quattro consecutive e strappare un biglietto per le finali NBA, dove li aspettano quei Warriors.
Durant inizia la serie ai box, cercando di recuperare da un infortunio occorsogli durante il cammino dei suoi. Cousins stringe i denti, recupera in modo insperato, mette piede in campo per gara uno. Che comunque si conclude con il vantaggio Raptors.
In gara due è il turno di Klay Thompson, che salterà di conseguenza la partita seguente, per rientrare clamorosamente nella quarta sfida, pur non bastando: Lowry e compagni si portano sul 3 a 1, e con le spalle al muro Durant decide di forzare il rientro.
Gara cinque la vincono i Dubs di un punto, ma KD si frantuma il tendine d’Achille dopo appena 12 minuti in campo, giusto in tempo di mettere tre triple su altrettanti tentativi. Sembra l’apoteosi del dramma, ma per quanto la situazione appaia assurda, non abbiamo ancora visto nulla. Nella sesta e decisiva sfida Thompson mette 28 punti giocando in modo divino, prima di infortunarsi al legamento crociato del ginocchio. Rientra in campo per segnare due liberi che gli permetterebbero un eventuale ritorno entro la sirena, che non avverrà. E decreterà il primo titolo di una squadra non statunitense nella NBA.
Sono i Raptors ad alzare al cielo il Larry O’Brien Trophy, e seppur con mille attenuanti, lo fanno in modo sorprendente. Forse destinato a restar inedito a lungo.
Le finaliste impreviste
Per quanto riguarda questa categoria, potremmo dire che di squadre da citare ce ne sono a bizzeffe, senza scavar troppo. Certo, l’aggettivo “imprevisto” in questo caso più che mai ha valenza soggettiva, e se a prima vista l’elenco appare lunghissimo, possiamo limitarci a citare tre esempi in particolare. Si tratta di squadre difficili da pronosticare a quel livello, in quel momento. E per questo sconfitte già in partenza, almeno in termine di pronostico (inevitabilmente rispettato).
Si parte dalla stagione 1980/81, con gli Houston Rockets che non sono ancora quelli di Ralph Sampson e Hakeem Olajuwon, ma una versione molto meno conosciuta. Capace di chiudere la stagione regolare con un record perdente, 40 vinte e 42 perse. Ma comunque sconfitti con l’onore delle armi dai Celtics di Bird alla Finals, in sei partite.
A roster ci sono figure divenute leggendarie in città, ma poco ricordate in campo dagli appassionati, come il folletto Calvin Murphy, Robert Reid e Rudy Tomjanovich in versione giocatore. Ma soprattutto sotto canestro c’è un Moses Malone devastante, spesso serenamente sopra i 30 punti ed i 10 rimbalzi.
Eliminano al primo turno i campioni in carica dei Lakers, sudando sette partite contro gli Spurs di Gervin prima di conquistarsi le Finals superando i Kansas City Kings. Altra squadra raramente rammentata, straordinariamente ad un livello tanto alto. Sconfiggere Boston e la sete di vittoria di Larry è impresa proibitiva, come già accennato. Ma serve la sonora sconfitta nel pivotal game di gara cinque per rompere gli argini, di una sfida che si era mantenuta equilibrata per i primi quattro episodi.
Ad un livello simile, anche i New Jersey Nets del 2001/2002, letteralmente “sweepati” via dai Lakers di Kobe, ma comunque destinati a ritornar in finale l’anno seguente. Stavolta a vantaggio dei San Antonio Spurs.
È la squadra guidata da un Jason Kidd al massimo della consapevolezza sui suoi mezzi (apparentemente infiniti a tratti), figlia di anni di scelte vincenti, sommando a roster una serie di pick da ritenersi fortunate.
Kenyon Martin, Keith Van Horn, Kerry Kittles e Richard Jefferson sono diretta conseguenza della lungimiranza della dirigenza, ed il playmaker originario di Oakland funziona da collante vero.
Quando giungono per la prima volta in finale (dopo aver vinto 52 gare in stagione), lo fanno da squadra comunque ben considerata, viste le alternative presenti ad est, non esattamente temibili. Dopo aver sconfitto i Celtics di Paul Pierce e Antoine Walker, per i Lakers di Kobe e Shaq rappresentano poco più di una passeggiata. Ma il solo fatto di arrivarci – e tornarci con coscienza 365 giorni dopo – merita ampiamente una menzione.
E sempre guardando ai Lakers campioni, chiudiamo questa carrellata con un salto in avanti di non troppi anni. Si tratta del 2008/2009, quando tutto il mondo sogna di vedere Kobe Bryant battagliare con LeBron James all’ultimo atto. L’allora giocatore dei Cleveland Cavaliers trascina i suoi a 66 vittorie stagionali, conquistando un meritatissimo premio di MVP. E con i Lakers che perdono appena una partita in più, lo scontro a distanza appare già scritto nell’incrocio definitivo.
Invece dalle Eastern Conference Finals escono degli improbabili Orlando Magic, che si fanno beffa dei Cavs in sei partite prima di vincere appena la gara della bandiera alle Finals con i gialloviola.
Sono gli anni in cui la lega appare ai piedi di Dwight Howard in versione Superman, che in Florida rimanda all’ultima volta a quel livello, trascinati da un altro grande centro che altro non era che Shaquille O’Neal.
Ed il fatto che riescano comunque a superare i gialloviola in gara tre, appare ancora adesso una grande impresa, soprattutto rispolverando il roster a disposizione di Stan Van Gundy, attorno all’atletico Dwight.
C’è un Hedo Turkoglu nel momento migliore in carriera, un Rashard Lewis in procinto di intraprendere una caduta inesorabile negli anni a seguire, poi un JJ Redick con poca fiducia, e gli exploit di un outsider come Jameer Nelson. Sostanzialmente poi, nient’altro.
Un po’ poco per una finalista, che comunque può fregiarsi di aver messo un tassello in quello che sarebbe stato il primo divorzio tra LeBron James e i Cavs, configgendo quest’ultimi nonostante il re e le sue prestazioni mostruose.













































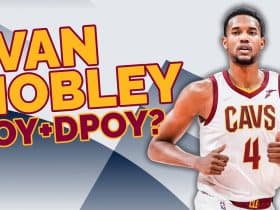



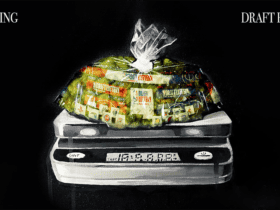








Lascia un Commento
Mostra i commenti