“Comfort zone” è una delle tante espressioni che nel ventunesimo secolo sono diventate sostanzialmente delle macchiette, ma vi chiedo di non farvi venire immediatamente la nausea e di provare a seguirmi. Una definizione spicciola ma accettabile in psicologia potrebbe essere “condizione mentale in cui l’individuo agisce sentendosi in controllo dell’ambiente circostante, con bassi livelli di ansia e stress e la sensazione di sentirsi a proprio agio”. La comfort zone è dunque uno stato mentale di per sé positivo, poiché presuppone un livello costante e ottimale di prestazione; come ormai tutti sanno, però, il mantra dei giorni nostri è diventato uscire da questa sorta di gabbia dorata e andare a prendere a morsi un mondo che é lì fuori ad aspettarci!
Troppo? Sì, decisamente. Anche perché tecnicamente l’obiettivo dovrebbe essere in realtà allargare, in maniera ovviamente graduale, i confini di questa benedetta zona e dunque aumentare le situazioni in cui agire in assenza di stress.
Il tifoso, di qualunque sport si tratti, conosce bene questo tourbillon di stati d’animo e tende ad essere particolarmente sensibile ad ogni cambiamento, sia in un verso che nell’altro. A chiunque è capitato di incontrare, per esempio, il maicontento: non va mai bene nulla, è tutto completamente da rifare e soprattutto l’erba del vicini è sempre, costantemente e indiscutibilmente più verde. Poi c’é l’aziendalista, malleabile, accondiscendente e strenuamente aggrappato alla fede nella dirigenza.
Le sfumature sono molteplici ed è impossibile individuarle tutte, ma guardandosi dentro è molto facile individuare alcune tendenze comuni. Chi scrive, ad esempio, ammette senza problemi una certa predilezione per quella che potremmo chiamare un’omeostasi sportiva: evoluzione sì, ma graduale. Nel dubbio, meglio la strada vecchia di quella nuova.
Per un ventennio abbondante i Dallas Mavericks hanno rappresentato una sorta di isola felice per chiunque avesse idee di questo genere. Un mondo come quello NBA è quanto di più lontano ci possa essere dalla concezione sportiva europea, soprattutto calcistica; la proprietà targata Mark Cuban, tuttavia, è forse la cosa più simile mai vista ad un compromesso paritario.
Una conduzione della franchigia che potremmo quasi definire famigliare, termine che assume un significato letterale se si guarda a Don Nelson, head coach e GM dal 1997 al 2005, e al figlio Donnie, suo successore alla scrivania fino al 2021. L’erede di Nelson Sr. come capo allenatore è stato inizialmente Avery Johnson, già giocatore dei Mavericks e assistente allenatore, rimpiazzato poi da Rick Carlisle nel 2008. Da lì, per i successivi 13 anni, Cuban, Nelson e Carlisle formeranno un solidissimo ed inscalfibile triumvirato, che porterà al felicissimo titolo del 2011 e alle un po’ meno felici stagioni successive.
Nella buona e nella cattiva sorte, come in un buon matrimonio, quei tre nomi sono stati i Mavericks in tutto e per tutto. Il rapporto con i giocatori storici è sempre stato viscerale, in particolare per Cuban: Nowitzki è il caso emblematico, certo, ma forse Chandler Parsons è stato colui che ha mostrato al meglio tutte le luci e tutte le ombre di questo approccio.
La lista dei grandi ritorni, poi, è piuttosto lunga: J.J. Barea, esule nel Minnesota dopo gli sfracelli delle Finals 2011, riportato a casa tre anni dopo e mai più lasciato andare; Devin Harris, pilastro dal 2004 al 2008 riaccolto a braccia aperte come veterano nel 2013; Jason Kidd, già in biancoblu sotto Donald Carter a metà anni ’90 e tornato più di dieci anni dopo a vincere il titolo (la sua attuale posizione di capo allenatore merita ovviamente un approfondimento a parte).
La grande stabilità ai piani alti si è tradotta pedissequamente in campo: dal 2001 al 2016, in corrispondenza degli anni migliori di Nowitzki, Dallas ha mancato i playoffs in una sola occasione, raggiungendo il titolo nel 2011, le Finals nel 2006 e le Western Conference Finals nel 2003. Per tutti i primi anni 2000 i Mavericks, dopo solo gli Spurs e i Lakers, sono stati una superpotenza costante nelle forche caudine dell’Ovest.
Facciamo ora un brevissimo passo indietro e torniamo solo per un attimo alla psicologia un tanto al chilo. Si tende sempre ad associare al concetto di stress una connotazione esclusivamente negativa, ma c’è in realtà un range entro il quale le performance possono essere addirittura migliorate.
Il post 2011 per Dallas non è stato certo un periodo di successo, con nessuna serie di playoffs vinta fino al momento del ritiro di Nowitzki. Il naturale calo fisico e tecnico del tedesco è stata ovviamente la ragione principale della fine del ciclo, ma negli ultimi anni le critiche al front office nella sua interezza erano aumentate sempre di più. La sensazione, a torto o a ragione, era che questa eterna stabilità fosse ormai stagnante e che ci fosse bisogno di un cambio di passo deciso per restare al passo coi tempi. L’occasione, ça va sans dire, l’ha fornita il numero 77.
Luka Dončić, fin dai suoi primissimi vagiti su un parquet NBA, si è dimostrato qualcosa di diverso, in grado di mandare in cortocircuito i cultori dello “stile europeo” da contrapporre a quello americano. Lo sloveno ha preso a piene mani ora dall’uno e ora dall’altro stereotipo, allontanandosi da tutti e dunque anche da Nowitzki, che pure l’ha preso per mano influenzandolo parecchio nell’unica stagione trascorsa insieme.
Eppure, per le prime tre stagioni di Luka, la sensazione è stata quella di un semplice ponte tra un uomo franchigia dei Mavericks e l’altro. Dončić, almeno stando a quello che riportano le indiscrezioni, è stato fortemente cercato e voluto innanzitutto da Nelson, che lo conosce da quando era un adolescente. Da qui in poi la storia è arcinota: la crescita vertiginosa del 77 che ha costretto Dallas ad accelerare rinunciando a Dennis Smith Jr. e cogliendo l’occasione di accaparrarsi Kristaps Porziņģis (la somiglianza tra il lettone e Nowitzki sarà sicuramente una coincidenza), la solita maestria di Carlisle nel rendere “Luka, KP e un mucchio di ottimi settimi di rotazione” uno dei migliori dieci attacchi della NBA, le solite ottime Regular Season uscendo bene ai playoff contro squadre indiscutibilmente più competitive.
Digitiamo Giugno 2021 sul pannello della DeLorean: Dallas ha appena perso per il secondo anno consecutivo al primo turno contro i Los Angeles Clippers, al termine di una serie ancora più agguerrita della precedente. Il rammarico tra i tifosi è presente, certo, ma l’idea generale è più che altro quella di trovarsi all’inizio di un fisiologico processo di crescita. Dončić ha 22 anni e può solo migliorare, KP prima o poi una stagione intera da sano la farà. Magari quest’anno un free agent decente arriva davvero. E poi insomma, mica incontreremo sempre i Clippers!
Tutto come sempre, quindi. Moderato ottimismo, niente panico e passi di bimbo.
Vero?
Nel giro di tre giorni, due terzi del triumvirato saltano per aria senza il minimo preavviso. L’addio di Carlisle è tutto sommato sereno, con il mai del tutto compreso endorsement nei confronti di colui che poi diventerà effettivamente il suo successore, mentre purtroppo con Nelson volano gli stracci. Al momento della scrittura dell’articolo, l’ex GM e i Dallas Mavericks andranno a processo l’uno contro gli altri nel dicembre 2024: Nelson sostiene di essere stato ingiustamente licenziato per aver riportato le molestie sessuali subite da suo nipote durante un colloquio con un uomo di fiducia di Mark Cuban, mentre i Mavericks negano l’accaduto e sostengono che Donnie avesse minacciato di rivelare l’omosessualità dell’uomo se le sue richieste contrattuali non fossero state soddisfatte. Decisamente non la conclusione auspicata per una storia d’amore così lunga.
Nico Harrison e Jason Kidd, dunque. Arrivati a stretto giro l’uno dall’altro, talmente stretto che si vociferava fossero parte di un unico “pacchetto”. Comunque sia, chi si aspettava la completa rivoluzione rimane deluso: al di là di qualche esperimento iniziale Kidd mette mano in maniera molto lieve allo stile di gioco lasciatogli in eredità da Carlisle, persistendo con un attacco eliocentrico che quando il sole è costituito da Luka Dončić resta quanto di più simile ad un’assicurazione sulla vita (o sulle 40 vittorie) si possa trovare in NBA.
La squadra galleggia fino a febbraio, poi Porzingis viene scambiato e i Mavs prendono il volo, probabilmente per un mero fattore di addition by subtraction: il lettone, su cui mai ho voluto gettare la croce, aveva esaurito il suo ciclo in Texas e la sua cessione si è poi rivelata ottima per tutte le parti in causa.
Abbiamo quindi individuato il punto di rottura, no? Nelson ha aspettato Porzingis per due stagioni e mezza, mentre Harrison ha impiegato solo quattro mesi per disfarsene. Ebbene, a parere di chi vi scrive bisogna attendere ancora un attimo.
L’addio di KP è stato, in retrospettiva, un gattopardesco tentativo di cambiare tutto per non cambiare nulla. Il gruppo con cui Dallas si è giocata le sue chances nel 2022 era lo stesso degli anni precedenti ed era arrivato probabilmente al suo apice.
Rotazioni cortissime (si gioca di fatto in 6, più Powell che è titolare solo di nome e Bertans a riempire dieci minuti tirando tutto ciò che gli passa per le mani), giocatori che si conoscono a memoria e impronta tattica ben definita. Dončić al centro di tutto, Brunson e Dinwiddie ad alternarsi al suo fianco con la palla in mano, Bullock, Finney-Smith e Kleber a farsi il mazzo in difesa e ad aprire il campo in attacco. Punto e stop. Asciutto, essenziale ed efficace (chiedere ai Suns), per quanto sicuramente limitante ad alti livelli (chiedere ai Warriors).
Ora, a questo punto si entra nel campo delle supposizioni. Quanto ha influito il “tradimento sportivo” di Jalen Brunson sulle decisioni di Harrison? Nella sua testa c’era comunque l’idea di cambiare o ha dovuto fare di necessità virtù? Non lo sapremo probabilmente mai, ma nulla mi toglie dalla testa che l’acquisizione di Christian Wood, avvenuta sostanzialmente a titolo gratuito, fosse concepita come un ritocco ad una squadra già rodata e che necessitava da lì in poi di qualche aggiustamento.
In quell’estate, però, ad ogni tifoso di Dallas non resta altro che la voglia di urlare tutta la delusione del mondo a Brunson alla maniera di Obi Wan Kenobi, per poi restare a guardare una squadra che improvvisamente è una coperta cortissima.
Tutti i comprimari disputano la peggior stagione della carriera, l’aggiunta di McGee non porta nulla e i numeri di Wood, in apparenza buoni, sono vuoti come il tronco cavo di un albero. Dončić tira la carretta come al solito, ma si torna sempre lì: si galleggia. E ora la sensazione è sempre più quella di girare in tondo.
Ecco, questo è il contesto in cui Kyrie Irving arriva ai Mavericks. Nessun panic button premuto, nessun vetro rotto causa emergenza. Semplicemente un giocattolo che si è rotto da solo e una nuova maniera di aggiustarlo, completamente in controtendenza con quanto visto in passato.
Pensandoci bene, come poteva essere altrimenti? Harrison è un uomo d’affari, sicuramente immerso nel basket fin da ragazzo ma abituato a ragionare per perdite e profitti. Forse sto romanticizzando un po’ il tutto, ma una mossa del genere la può fare solo qualcuno al di fuori della Famiglia. La leggenda è la solita e viaggia per parole magiche: il celeberrimo “governo tecnico” che ha il coraggio di fare impopolari manovre “lacrime e sangue”. Volendo stare in un perimetro sportivo, Nico è come il Team Principal agognato da tutte le nobili decadute della Formula 1, che arriva da fuori con una reputazione che lo rende intoccabile e con i favori della proprietà rivoluziona l’intero reparto corse mettendo fine all’aria stagnante che da troppo tempo si respira.
L’inguaribile infatuazione dell’epoca post-moderna per l’uomo forte meriterebbe ben altro approfondimento: ciò che conta per noi, ora, è capire che da qui in poi la strada è tracciata. Tutte le mosse successive appaiono come conseguenze inevitabili, piccole tessere di un puzzle composto con un modus operandi ben preciso. Bullock, fuori da quel collettivo, vale un taglio alla prima occasione buona. Al Draft si va aggressivi, cedendo e assorbendo contratti pesanti pur di riuscire a scegliere il prospetto più apprezzato, senza attendere passivamente il proprio turno ed optare per il best player available.
E se Grant Williams non funziona? Poco male, c’è sempre un altro febbraio, un po’ come Fever Pitch. Via lui e dentro P.J. Washington, che problema c’é? Serve metterci dentro altre scelte al primo giro per farla funzionare? Beh, non le lasciamo mica lì a far la muffa.
Me lo immagino proprio, il vecchio Donnie, a mettere dentro scelte su scelte per cambiare per la seconda volta in sei mesi il terzo violino della squadra, senza ovviamente alcuna garanzia che quest’operazione costituisca una svolta sostanziale per le sorti della squadra. Me lo immagino, sì. In preda ad una sincope al solo pensiero.
Siamo alla fine di questo agonico articolo, che è in realtà in gestazione da mesi. Perché alla fine per spiegare Klay Thompson ai Dallas Mavericks non serve necessariamente parlare DI Klay Thompson ai Dallas Mavericks. Cosa volete che vi dica? Che l’eccitazione di trovarselo in angolo con le voragini di spazio generate dal dynamic duo non riesce a superare la preoccupazione riguardante la chimica di squadra e la tenuta difensiva? Perché, cos’altro vi aspettavate da uno cresciuto a pane e cautela?
Lasciatemi qui, ancora per un paio di notti, a guardare per la milionesima volta Cuban che lascia il Larry O’Brien Trophy 2011 nelle mani di Donald Carter, la Famiglia che addirittura onora la Famiglia precedente. Poi da venerdì torno in trincea carico di hype per la stagione che arriva, promesso, ma anche se so che la sveglia sta per suonare voglio stare sotto le coperte fino all’ultimo secondo. C’é da capirmi, sapete. Il mio POBO, interpellato su Klay, ha in sostanza dichiarato con tranquillità disarmante che visto che nelle Finals ci è mancato il tiro dall’arco lui ha deciso di prendere uno Splash Brother. Così, come se ordinasse il caffè al bar. Verrà a me la sincope, uno di questi giorni.
Taglia i legami, uccidi i tuoi cari e riprendili solo quando da solo te la cavi.
Marracash













































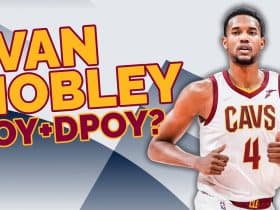



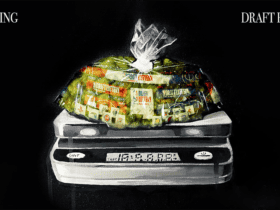








Lascia un Commento
Mostra i commenti