Con le prime Conference Finals nella storia della franchigia, i Los Angeles Clippers coronano già la miglior stagione di sempre rispetto ad un loro possibile piazzamento. A prescindere dagli infortuni, dal potenziale, dal risultato dello scontro con Phoenix che può decretare l’accesso all’ultimo atto della postseason. L’inversione di rotta operata dalla dirigenza (nella determinata e potente figura di Steve Ballmer), cancella anni di sbeffeggiamenti e risultati cestistici imbarazzanti, dominati da protagonisti improbabili magari recitanti il ruolo di franchise player loro malgrado.
Anche per questo può essere interessante guardarsi indietro, nel bel mezzo della run playoff più produttiva dell’ex Lob City: per capire quanta acqua è passata sotto i ponti, e visualizzare come ci si può evolvere da barzelletta conclamata, a squadra. Un’opportunità che lo sport statunitense regala a tutti, in modo molto democratico; ma che la cosiddetta “seconda squadra di Los Angeles” ha impiegato molto tempo a cogliere.
Anche perché il peccato originale lo troviamo molto indietro nel tempo, quando ancora i Clippers si chiamavano Braves, ed esordivano nella lega in quel di Buffalo, molto lontani dalla Città degli Angeli.
Con l’opportunità di scegliere un idolo “di casa” come Calvin Murphy da Niagara University, gli antenati dei Clips optano per tale John Hummer. Un uomo che produrrà poco meno di 7 punti e 5 rimbalzi di media in sei stagioni da professionista. Peccato, perché sul finire degli anni ’70 – dopo aver selezionato Bob McAdoo e Adrian Dantley – le prospettive di squadra non erano così malvagie, e l’aggiunta al suo interno della point guard divenuta leggendaria in quel di Houston, avrebbe probabilmente determinato una storia diversa.
Non dimentichiamoci che in quel periodo – con i grandi mercati boccheggianti e squadre imprevedibili ad alternarsi al titolo – esistevano spazi concreti per emergere, e magari raggiungere la vetta in modo improvviso. Basta pensare ai Bullets di Unseld e Hayes, ai Sonics di Sikma e Dennis Johnson, ai Blazers di Bill Walton.
Invece, gettando letteralmente al vento due scelte del potenziale di McAdoo e Dantley, non solo i Braves rimangono nel quasi anonimato, ma l’allora proprietario John Y. Brown jr. completa un bizzarro valzer di passaggi proprietari lasciando la franchigia a tale Irv Levin che – da owner dei Celtics, ma californiano di nascita– pensa bene di trasferire il tutto a San Diego.
Una città che non dimostrerà mai grande interesse, poco stimolata da una squadra dove passano giocatori come Tom Chambers, Terry Cummings e grandi “nomi” come Bill Walton e Norm Nixon. Che non bastano per lasciar proseguire il tutto, con la cessione al famigerato Donald Sterling e l’approdo consequenziale ai Clippers dopo sei stagioni nell’estremo sud dello Stato.
Il resto è storia nota, con i Los Angeles Clippers destinati ad essere principalmente destinazione in cui “svernare” per atleti poco inclini al sacrificio, oppure “punizione” per chi si ritrovi lì destinato, in qualche trade malcapitata. Almeno fino all’avvento del trittico formato da Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan guidato da Doc Rivers, che cambia la percezione della franchigia nel mondo NBA, alimentandone un futuro evidentemente radioso decretato dalla radiazione di Sterling per i fatti ben noti, fino ad oggi.
Considerando quanto singolare appaia il fatto che una franchigia con oltre 50 anni di vita, non abbia un numero ritirato che sia uno, proviamo a raccontare cinque giocatori che – finiti nel dimenticatoio di anni volutamente bypassati dalla memoria – avrebbero potuto meritarsi il riconoscimento.
World B. Free
Siamo ancora a San Diego, è bene premetterlo, ma le due clamorose stagioni disputate da questo personaggio dal nome bizzarro, meritano indubbia menzione. Perché nei primi due anni californiani della franchigia, Lloyd Bernard Free (questo il suo nome di battesimo) trascina i suoi a 78 vittorie complessive su 164 gare. Un record non sufficiente per la postseason, ma comunque dignitoso. Guardia tiratrice selezionata con la pick 23 dei Sixers nel Draft’75 , in due anni produrrà poco meno di 30 punti di media, conquistando un All-NBA Second Team e una convocazione per la partita delle stelle.
E lui, da un punto di vista offensivo, è effettivamente un giocatore strepitoso. Capacissimo di spezzare le difese in penetrazione, punta il ferro con efficacia guidando la lega per falli subiti e liberi tentati. Che realizza con discreta continuità, rappresentando anche una minaccia in post oltre che mostrando capacità balistiche di tutto rispetto. Free tiene medie offensive pazzesche tirando più o meno da ovunque, anche da distanze siderali, utilizzando ampie parabole ad arcobaleno.
Nel biennio passato a San Diego finisce sempre secondo dietro George Gervin, in materia di realizzazioni stagionali, e rappresenta la prima vera sensazione di un’esperienza destinata a naufragare rapidamente, come già detto. E poi c’è quel nome, che decide di cambiare seguendo un assonanza utopica che narra di libertà e comunanza tra paesi distanti nel globo, almeno in apparenza. Perché per quanto singolare appaia, il senso reale è molto più materiale, originato nei campetti di Brooklyn dove aveva passato la sua infanzia.
Considerando quella predisposizione a tirare da ovunque, segnando più o meno sempre, il soprannome “World” gli viene incollato in modo quasi naturale, vista quell’inclinazione a colpire da ogni parte del campo, inteso come il tutto in uno sfondo cestistico. All around the world. Decide di trasformare quel nickname in un nome nel 1981, quando ormai gioca – e bene – per i Warriors, ma un giocatore di quel talento con un nome tanto evocativo, meriterebbe di esser comunque ricordato. A maggior ragione in una franchigia dove per adesso, non si ricorda nessuno.
Danny Manning
Passati a Los Angeles nel 1984, i Clippers inanellano un disastro dietro l’altro, partendo dalle 12 vittorie stagionali nel 1987 e migliorando il loro record con appena 17 l’anno seguente. La squadra sembra un parcheggio per mestieranti poco ispirati, ma con la prima scelta assoluta del 1988 arriva Danny Manning, talento cristallino appena laureatosi campione NCAA con Kansas da assoluto protagonista.
Le aspettative sono altissime, considerando quanto l’aggraziata power forward di 208 centimetri avesse fatto innamorare di sé i principali osservatori nazionali. Con una gamma offensiva di assoluto livello, e quell’attitudine rara da cigno nero, suggerisce un futuro radioso. Peccato che dopo appena 26 gare da professionista si rompa il legamento crociato anteriore del ginocchio, rivelando anche una certa fragilità fisica, oltre che le sue doti. Il miglioramento, a livello di record, appare impercettibile: 21 vittorie su 82.
Ma in attesa della sua forma migliore, la squadra inizia a strutturarsi come se si trattasse davvero di una franchigia NBA capace di programmare un minimo di futuro, e nella offseason arriva un core potenzialmente nel fiore degli anni, sul quale potrebbe esser lecito anche puntare un paio di monetine.
Nella stagione 1991/92 infatti giungono anche gli agognati playoff, con un’uscita assolutamente dignitosa – in cinque partite – contro i Jazz di Stockton e Malone.
Si tratta della prima vera stagione completa in campo per Manning, onorata con una crescita statistica che narra 19 punti, quasi 7 rimbalzi e oltre 3 assist per gara. Con l’aggiunta di un recupero ed una stoppata abbondanti per gara.
Con l’arrivo di Larry Brown in panchina, i Clippers ritornano nuovamente in postseason grazie ad un’annata ulteriormente migliorata della sua stella, che stavolta esordisce anche all’All-Stars Game chiudendo con oltre 22 punti per incontro. E tornando ad attirare ben più di un estimatore, malgrado l’epilogo appaia similare all’anno precedente, con eliminazione al primo turno dopo cinque partite, stavolta per mano dei Rockets.
Da franchise player consolidato, Manning replica l’happening di metà stagione anche nel 1993/94, finendo però nella tipica trade del periodo, da oggetto del desiderio degli Atlanta Hawks in cerca di un cambio di rotta, stanchi dei fallimenti occorsi sotto la guida in campo di Dominique Wilkins. L’arrivo di uno scontento Nique desta comunque scalpore, con la squadra losangelina che ricade pesantemente nella mediocrità ed un Manning che – ironia della sorte – proiettato in palcoscenici da aspettative più elevate, avvia in anticipo un declino imprevisto per la sua carriera. Proverà a riciclarsi come arma in più nei Suns di un già stanco Barkley, in cerca di soluzioni per il ritorno alle Finals, senza troppo successo.
Tuttavia, guardando ai Clippers dei nineties, difficile non pensare a lui come tra i migliori visti passare. Se non in coppia con il prossimo nome a seguire.
Ron Harper
Quando pensiamo a Ron Harper viene in mente la figura scaltra del vincente che vorresti sempre nella tua squadra, non fosse altro che per i cinque anelli conquistati con Bulls e Lakers. Da pedina fondamentale nella scacchiera disegnata da Phil Jackson e Tex Winter. In realtà, il nativo di Dayton (Ohio) ha vissuto almeno due vite ben diverse prima di approdare alla corte di Jordan e del giovane Kobe, ed una di queste è passata proprio con la seconda squadra di Los Angeles, da stella assoluta.
Scelto dai Cavaliers con l’ottava pick assoluta del 1986, Harper è (né più, né meno) un realizzatore strepitoso, con doti atletiche che lo rendono anche affidabilissimo difensore, all’interno di una squadra che battaglia molto volentieri per i vertici di Conference.
Dopo tre stagioni di ottimo livello, viene spedito ai Clippers a Novembre, con l’intento di recitare il ruolo di punta offensiva in quella squadra che – appena selezionato Manning – iniziava a sognar di scrollarsi di dosso la nomea di fanalino di coda. Con a roster un allora ottimo Charles Smith ed il talento instabile di Ken Norman, oltre al totem Benoit Benjamin.
Riesce a farsi vedere per appena 28 partite, prima di rompersi il crociato anteriore e disputarne appena 39 nel campionato seguente. Il suo rientro a pieno regime nella stagione 1991/92, coincide con la prima conquista della postseason introdotta precedentemente, e grazie all’avvento di Larry Brown il buon Ron vive le tre migliori stagioni probabilmente in carriera.
Certo, le conseguenze dell’infortunio lo costringono a trasformare il suo gioco, limitandone atletismo e viaggi sopra il ferro, ma nel triennio conclusivo della sua esperienza Clips si stanzia sempre attorno ai 20 di media, accompagnandosi con oltre 5 rimbalzi e quasi 5 assist. Come per Manning, una volta considerata la tenuta atletica del giocatore – in questo caso da sommarsi con una maturità cestistica raggiunta – arriva la chiamata da chi ha qualche ambizione in più. Si tratta dei Chicago Bulls, momentaneamente orfani di Jordan ed in cerca di un realizzatore nello spot di guardia tiratrice.
Un ruolo che Ron Harper non dovrà mai ricoprire con efficacia, considerando che si tratta della stagione 1994/95, e che MJ rientrerà giusto in coda della regular season, togliendolo da ogni imbarazzo e regalandogli quel ruolo specialista con cui coronerà una carriera di assoluto successo personale. Anche grazie agli anni da leader assoluto in quel di Los Angeles.
Loy Vaught
Probabilmente, almeno che non siate dei die hard fans dei Clippers che nessuno voleva vedere, nessuno saprà dar un volto al nome di Loy Vaught, nonostante le otto stagioni passate a Los Angeles. Non c’è niente di male, si trattava di anni piuttosto brutti per la franchigia, ma la seconda parte dei nineties è senza dubbio la sua. E non a caso, se andate a scandagliare nelle poco interessanti classifiche sui giocatori dimenticati nell’era Sterling, a lungo si parla di lui tra le migliori power forward di sempre nella storia della squadra.
Certo, prima dell’avvento di Lob City e quindi delle epoche recenti, ma la sua efficienza offensiva è lì a dimostrarlo, partendo proprio dai nudi numeri. Nelle tre stagioni centrali del decennio salta appena 4 partite totali, dimostrandosi scorer affidabile e rimbalzista granitico, reggendo più che bene le sportellate copiose che non venivano lesinate ai tempi sotto canestro.
Formatosi cestisticamente a Michigan, arriva in NBA con la tredicesima scelta nel Draft del 1990, e dopo tre stagioni da rodaggio da ottima soluzione di second unit, viene catapultato tra i titolari senza tradir emozioni né cali di rendimento. Anzi, nel 1995 produce oltre 17 punti per gara, raccogliendo sostanzialmente 10 rimbalzi ad uscita, replicando gli stessi numeri nei due anni seguenti e dimostrandosi una delle poche garanzie in cui ormeggiare una squadra che non smette di imbarcar acqua da ogni fessura.
Certo, i risultati di squadra non depongono proprio in suo favore, sebbene nel 1997 i Clippers riescano addirittura a far una comparsata ai playoff con un record perdente (36 vinte, 46 perse), per venir agilmente asfaltati dagli Utah Jazz.
Ma per dedizione e concretezza – oltre che per l’anima spesa in campo – la maglia di Vaught avrebbe anche potuto meritar una menzione, se mai la franchigia avesse deciso di appenderne qualcuna. Almeno per quanto visto prima dell’avvento del nuovo millennio, in cui le cose non è che migliorano subito, ma iniziano a farsi finalmente interessanti.
Elton Brand
Con la prima scelta del Draft del 1998, i Los Angeles Clippers selezionano Michael Olowokandi. Un centrone nigeriano che esordirà prima alla Virtus Bologna (complice il lockout) e poi in NBA, giocando tre gare in Italia che appariranno profetiche rispetto al prosieguo della sua carriera. In poche parole, una gran bella occasione sprecata, l’ennesima.
Un anno dopo, la chiamata da primo della classe tocca a Elton Brand da Duke. Stavolta un giocatore muscolare, inamovibile, capace anche di realizzare tanto sotto i tabelloni. Peccato che i destinatari della pick fossero i Chicago Bulls.
Nella Windy City però decidono misteriosamente di disfarsene dopo due stagioni, spedendolo proprio nel purgatorio losangelino in cambio di Tyson Chandler e Brian Skinner. Nel frattempo però, in casa Clippers si inizia a prestar un minimo più di attenzioni rispetto ai rookie in arrivo, finalmente selezionando qualcosa che possa seriamente tornar utile nell’offrire uno spettacolo dignitoso al (poco) pubblico di affezionati.
Arrivano quindi talenti come Cory Maggette e Darius Miles, Quentin Richardson e Lamar Odom, e con l’aggiunta sotto canestro di una macchina costante come Brand, la squadra vince più della media recente, ma soprattutto diverte. E questo appare un miglioramento non da poco, dopo anni di depressione.
Inevitabilmente, per il porto di mare che la franchigia sostanzialmente rappresenta, non tutti restano e gli entusiasmi si raffreddano velocemente. Ma Brand si impone come costante e perno attorno al quale provare episodicamente a ricostruire, fino alla stagione 2005/06, in cui produce il suo top in carriera. Poco meno di 25 punti, 10 rimbalzi abbondanti e 2.5 stoppate per incontro, e miracolosamente la squadra funziona altrettanto bene.
In panchina c’è Mike Dunleavy, ed arrivano a supporto Cuttino Mobley ed un vecchio volpone come Sam Cassell (oltre al cadavere di Vin Baker, ma lasciamo perdere). In regular season vincono la bellezza di 47 partite, eliminando clamorosamente i Denver Nuggets di Carmelo Anthony e Andre Miller al primo turno.
Si tratta di un risultato storico, perché per trovare un passaggio alle semifinali di Conference nella storia della franchigia prima di allora, bisogna saltare indietro alla stagione 1974/75. E si, si chiamavano ancora Buffalo Braves.
Al secondo turno li aspettano i Phoenix Suns di Nash e D’Antoni, in piena era del “seven second or less”. La serie si preannuncia un bagno di sangue, ma i Clips riescono sempre a rispondere ad ogni sconfitta subita, forzando una clamorosa gara 7, pur venendo liquidati infine con 20 punti di scarto.
Per Elton Brand una serie da 30.9 punti, 10.4 rimbalzi, 4.7 assist e 3.1 stoppate. E per buona pace di Loy Vaught, rispetto a quel discorso della “miglior power forward nella storia della franchigia”, potrebbe essere sufficiente fermarsi qui.
Servirà i Clippers sostanzialmente per un’altra stagione a seguire, sempre stanziandosi attorno ai 20 e 10 in punti e rimbalzi, prima di rompersi il tendine d’Achille nell’estate 2007 e disputare solo gli ultimi otto incontri della sua settima stagione in squadra. Prima di passare ai Sixers, restando comunque – fra tutti i citati fin qui – il più meritevole di onorato ritiro della jersey nelle stagioni inguardabili della franchigia.
Epoche che appaiono lontane più che mai, mentre Paul George e la chimera di un (improbabile?) ritorno in corsa di Kawhi Leonard, ci regalano oggi una squadra con il vento in poppa, verso l’obiettivo delle prime Finals di sempre nella loro storia.













































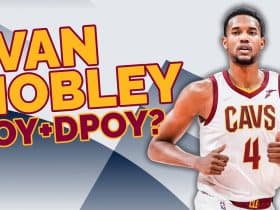



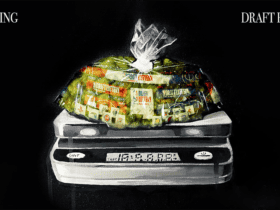










Lascia un Commento
Mostra i commenti