Alla sirena conclusiva del match dello Staples Center dello scorso 11 marzo, in pochi avrebbero potuto scommettere sui Golden State Warriors in ottica play-in. La partita finisce 130 a 104 per i Clippers, e la squadra allenata da Steve Kerr incassa un parziale di 17 a 31 nel secondo quarto, per tornare dagli spogliatoi ancor più spaesata, concedendo 45 punti agli avversari nel solo terzo periodo.
Il gruppo è sostanzialmente al completo (che manchi Klay Thompson ormai è consolidato), ma scovare un lato positivo all’interno di una prestazione simile sembra impresa ancor più complessa che sperar di risollevare la stagione. Che appare in caduta libera.
Stephen Curry chiuderà con appena 1 su 8 da dietro l’arco, tirando complessivamente 6 su 16 dal campo in 27 minuti di impiego, per 16 punti. Durante un timeout si alza davanti ai compagni, grida per spronarli, o forse semplicemente si sfoga mollando ogni ormeggio, scoprendo il fianco alla frustrazione. È necessario dare una scossa.
Senza di lui e senza Draymond Green, meno di un mese dopo i Warriors perderanno con 53 punti di scarto a Toronto, con il record in vertiginosa discesa. La necessità di un cambio di marcia, di una conduzione solitaria, è probabilmente maturata in quel momento.
Da lì Golden State vince 16 partite sulle restanti 23, e Stephen tiene 37 punti di media dopo esser rientrato da un infortunio al coccige (in verità, mai superato nella sua completezza). Con Klay ad incitare al massimo dalla panchina, il prospetto Wiseman rimandato a momenti migliori e Kelly Oubre Jr. fuori per la fine della stagione, Steve Kerr torna ad impostare un sistema a sostegno della sua stella, dove si corre e si muove la palla, dove chiunque difende ed è in grado di render agevole la soluzione della prima opzione offensiva.
Il leader sale in cattedra, e chi timidamente invocava per lui un cammino riconosciuto da MVP, può alzare la voce con cognizione e senza paura di smentite.
La scorsa stagione si era conclusa con 15 vittorie e 50 pesanti sconfitte, la naturale esclusione dalla ripresa nella bolla di Orlando ed una lunghissima offseason nella quale riflettere per cercar soluzioni.
Il campionato 2020/21 narra, in sintesi, di 39 successi su 72 sfide, una duplice chance di agganciare il treno playoff sfumata in entrambi i casi al fotofinish, con più di un’attenuante. E con la consapevolezza che il contorno – strettosi attorno al suo perno – ha dato segnali di crescita importanti, seppur incapace di regger ritmo e concentrazione per 48 minuti totali. Il prezzo da pagare all’inesperienza.
La differenza sostanziale tra le due stagioni, al netto dei cambiamenti di organico e degli infortuni, è riconducibile alla presenza in campo di Steph, ed il suo singolo valore possiamo semplificarlo osservando la discrepanza in positivo tra le vittorie totali nel biennio. La sua crescita a livello di leadership – già spiccata, ma non possiamo scoprirla soltanto ora – palesa un evidente, ennesimo, scatto in avanti.
Che Golden State possa puntare al titolo è fuori ogni discussione, ma raggiungere il traguardo di una stagione vincente e non arrendersi alle vacanze anticipate (rispetto alle abitudini recenti, almeno), appare fondamentale, e lui lotta per quello.
Perché la stagione non passi invano, fissando basi concrete per la prossima e dando forma ad un supporting cast che possa resistere all’estate, in attesa del rientro di Thompson per il rinnovo degli obiettivi, con la speranza di tornare a competere per il Larry O’Brien Trophy. Condizione necessaria per uno come Curry, un game changer, un talento atipico che ha lottato contro ogni pregiudizio ponendosi senza dubbio tra i più grandi di sempre dopo 12 stagioni disputate in carriera.
Certo, quando si parla di MVP è risaputo che conta il record di squadra, e quello dei Warriors non li conferma certo ai vertici di Conference (di fatto, fuori dai playoff). Ma osservando l’evidente cambiamento di sorte con la singola presenza, quel riconoscimento non sarebbe una bestemmia, tanto da porre comunque il giocatore nella top 3 della lega.
Jokić ed Embiid hanno completato regular season complessivamente superiori, tenendo conto dei risultati di squadra di cui sopra. Stephen Curry non sarà il Most Valuable Player, ma il suo rendimento legittima una discussione in merito. Il tributo di LeBron James, è solo l’ultima opinione (per quanto la più rappresentativa) a conferma di tutto ciò.
Chi ha sottovalutato Steph?
Non sarebbe la prima volta in cui si sottovaluta Curry, la sua storia parla da sola. Inutile insistere sul potenziale imprinting paterno, il problema è sempre stato l’apparenza. O meglio, la struttura fisica.
Mentre Dell Curry inanellava apprezzamenti e successi in una ottima carriera da professionista, quando il figlio sembrava emergere con tutte le fatiche del caso, qualcuno lo poneva violentemente dietro a qualcun altro nei ranking di categoria.
Come quando venne ignorato dai più prestigiosi College della ACC dopo una carriera di tutto rispetto all’High School, per accasarsi a Davidson, conducendola al torneo NCAA vincendovi una partita dopo una vita.
O quando viene selezionato dietro a Ricky Rubio e Tyreke Evans nel Draft 2009, guardando ai pari ruolo. Accontentandosi di una comunque ottima settima chiamata assoluta, di quelle che evidentemente cambiano la storia di una franchigia.
Eppure anche con i Dubs, i primi anni di carriera vengono minati da infortuni e fastidi, da caviglie di cristallo, che fanno dubitare un po’ tutti sulla sua effettiva futuribilità. Prima delle 5 Finals consecutive, dei 3 titoli, del record di 73 vittorie stagionali, dei due MVP vinti (uno all’unanimità) e di tutto il resto che ben conosciamo.
Con la partenza di Kevin Durant e le conseguenze a lungo termine della sfortunata edizione 2019 dei playoff, Curry si è ritrovato indietro di quasi 10 anni, in una squadra tacciata da molti come senza futuro e poche speranze di ricostruzione.
Poteva essere l’ago della bilancia per indicare ai nuovi la strada da percorrere, ma la stagione precedente allo stop pandemico dura per lui appena 5 gare. Probabilmente avrebbe potuto tornare, ma il modo in cui la nave imbarca acqua e progressivamente si inabissa, lo convince a gettare la spugna molto rapidamente. Per buona pace di Kerr, e soprattutto di un abbandonato Green.
Come sarebbe rientrato in campo dopo un anno di stop? Domanda tutt’altro che retorica, con l’attenzione concentrata sulla ripresa del campionato che proietta lui ed i Warriors lontanissimi dai riflettori mondiali, ma qualcosa trapela. Sembra aver lavorato molto in palestra, soprattutto per rinforzare la parte superiore del corpo, ma non molti metterebbero la mano sul fuoco su una stagione di altissimo livello.
È un po’ come se ci fossimo abituati alla sua assenza, fino a non ricordarci bene del suo gioco e delle sue capacità.
Ed infatti, in 63 gare stagionali Curry ha chiuso con 32 punti, 5.5 rimbalzi, 5.8 assist, 48% dal campo e 42% da dietro l’arco in 34 minuti di impiego in media. Numeri essenziali che fotografano un tendenza opposta alle aspettative più pessimistiche, ed il miglioramento nel record di squadra di cui sopra, ne confermano l’impatto.
Quello che questi numeri non raccontano, però, è il trattamento ricevuto dalle difese avversarie che le rendono irreali per efficacia. Un qualcosa che non tocca a nessun’altro, nella lega odierna. Con l’innalzamento del livello delle sue prestazioni, Steph si è sempre più visto al centro dei gameplan difensivi avversari, spesso strutturati esclusivamente nella limitazione del suo gioco. Spesso e volentieri liberi di triplicarlo, malgrado avesse un uomo dedicato a guardarlo da vicino per tutto lo svolgimento dell’azione (vedi Dillon Brooks nelle ultime sfide con i Grizzlies) oppure raddoppi sistematici di corpi più voluminosi, per limitarne visuale di uscita.
Il modo in cui i Lakers – nei concitati minuti finali del play-in tra le due squadre – hanno dedicato un Caruso indemoniato sul numero 30 di Golden State, con sostegno di un accorrente Davis per conquistare un successo faticoso, ne rappresentano l’emblema.
Anche lì, dopo aver comunque portato a casa 37 punti con 6 su 9 da tre, le 6 palle perse a referto sono perdonabili se osservata la concentrazione su di lui da parte di una delle migliori difese della lega. E comunque, solo contro tutti, è andato ad una ricezione a metà campo dalla potenziale parità a fine regolamentari.
Con un roster claudicante a sostegno, i Warriors hanno comunque dimostrato di poter punire gli avversari se la triplice attenzione su Steph era tale da limitarne le capacità di conclusione. E stiamo parlando di un redivivo Wiggins, la rivelazione Poole, un emergente Toscano Anderson. Non esattamente specialisti conclamati ad inizio stagione.
Ripartire da Steph guardando a loro, è il modo migliore per impostare i lavori in vista del campionato 2021/2022.
Come escono i Warriors da questa stagione
La ricerca di una nuova identità da consolidarsi, per Golden State, era il tema primario a partire dalla conclusione anticipata della scorsa stagione. E l’assenza forzata di Thompson – palesatasi senza preavviso, quando la riabilitazione del giocatore sembrava in via di completamento – ha rallentato un processo che malgrado tutto, non si è concluso con l’obiettivo preferibile. La conquista della postseason.
Detto questo, i mesi di febbraio e marzo sono risultati decisivi per il consolidamento di una base, propedeutici per l’innalzamento definitivo del livello di Steph. Che comunque stava già giocando un campionato di altissimo livello, anche se le sue peculiarità venivano sostenute dal contorno con difficoltà.
Il naufragio delle aspettative nella duplice sconfitta ai play-in, può trarre tutto sommato in inganno, perché a voler cercare spunti positivi ne emergono comunque di superiori, rispetto alle bocciature che dovranno esser considerate nelle prossime settimane.
Intanto, le due partite son servite come coronamento di un metaforico percorso di training, con il clima playoff appena assaggiato, ma utile in materia di esperienza nella gestione delle pressioni in accompagnamento ai veterani del gruppo.
L’insuccesso può esser visto come il prezzo da pagare per la crescita dei “giovani”, e sia Curry che Green hanno sostanzialmente evidenziato questo con dichiarazioni ben speranzose verso il domani, abbracciando la faccia positiva della medaglia.
Un modo per darsi forza a vicenda, continuando a sostenersi come fatto durante la stagione, per non veder concluso un viaggio invano dovendo smantellare tutto ciò che non è il nucleo fondante del sistema: i due Splash Brothers, Draymond e ovviamente Steve Kerr.
Andrew Wiggins ha dimostrato caratteristiche mentali per poter stare al loro passo, rendendosi prezioso in entrambi i lati del campo, e mettendo in evidenza capacità tecniche riconosciute ma sopite nelle ultime stagioni anonime disputate. Da lui e dall’ottimo Jordan Poole arrivano le conferme più evidenti, in particolare per quanto riguarda quest’ultimo: perché seppur non fosse andato malissimo al primo anno nella baia (8.8 punti di media in 24 minuti di impiego nella sua stagione da rookie), quel campionato poteva anche non far testo per l’assenza di motivazioni in cui si è svolto.
Ed invece le ottime capacità di adattamento si sono palesate attraverso una crescita progressiva, visibile dai miglioramenti statistici in un minutaggio medio inferiore di impiego (12 punti con il 35% dall’arco ed il 43% dal campo, in 19 minuti in campo).
Discorso simile per Juan Toscano Anderson e Kent Bazemore, due role player che hanno vissuto percorsi vicini per importanza, seppur con qualche differenza. Se il primo ha pagato l’inesperienza ed il carico di responsabilità nell’estremo finale di stagione, il secondo si è dimostrato preziosissimo a sfruttare gli spazi lasciati vuoti dalle rotazioni avversarie, impegnate nel raddoppiare o triplicare Steph. Ma trattandosi di un prossimo free agent, non è detto che lo rivedremo in quel di San Francisco tra qualche mese.
Insomma, l’aver preparato una second unit più che sufficiente, gioca assolutamente a favore del progetto, che adesso necessiterebbe di un paio di innesti versatili con un minimo di esperienza, per alleggerire i carichi di Curry e del rientrante Thompson. Laddove Draymond Green – il facilitatore per eccellenza – potrebbe non bastare.
Molto probabilmente il tempo per gli esperimenti giovani potrebbe essere finito, quantomeno ritenendo sufficiente ciò che già esiste per evidenza, e che prenderà forma nelle prossime settimane. Anche perché dovrebbero esserci due buone scelte al primo giro del prossimo Draft (inclusa quella di Minnesota proveniente dalla trade per Russell, almeno che non sia top 3), da sacrificare almeno in parte sul mercato, magari insieme ad un Kelly Oubre Jr. che si trova decisamente tra i bocciati stagionali, non avendo convinto a pieno.
E poi, c’è James Wiseman. Un lungo per certi versi atipico e sicuramente pieno di potenziale da esprimere, sul quale sarebbe un crimine gettar la spugna dopo un campionato falcidiato dagli infortuni, seppur abbia dimostrato poca inclinazione all’inserimento nel gioco di Curry. E questo non è certo un plus.
Sarà pur arrivato con appena tre partite al College di esperienza – e per giunta in un contesto dalla preseason limitata ed il training camp risicato – ma il dato di fatto narra che la squadra è decollata solo dopo la sua uscita dallo starting five prima, e dalle rotazioni dopo (causa indisponibilità fisica, non lo dimentichiamo). Sacrificarlo significherebbe svenderlo in base al talento potenziale, e malgrado non abbia convinto nessuno, il tempo per lavorare sulla sua maturazione non manca.
Il che ci porta ad introdurre un concetto imprescindibile per chiunque voglia restare con i Warriors nelle prossime stagioni; lo stesso che i vari Poole, Wiggins e Bazmore sembrano aver capito ed applicato.
Adattarsi all’onnipotenza di Steph
Certo, anzitutto ci sarebbe da vedere se Curry in primis decide di estendere o meno con la squadra, ma i dubbi a riguardo non sembrano essere fondati. A parte ipotesi fantasiose che lasciano il tempo che trovano. A partire da questo punto – ed a tutela di quanto già detto – giocare in un gruppo in cui l’uomo che inizia l’azione e ne destina gli equilibri, è un talento dell’imprevedibilità di Steph, può non essere facilissimo in prima istanza.
Serve capacità di adattamento, intelligenza cestistica e soprattutto entrare nella forma mentis del sistema orchestrato da Steve Kerr, che si fonda sulla dinamicità e l’interscambiabilità dei due Splash Brothers, e le facilitazioni favorite da un all around come Green.
Inserirvi all’interno un giocatore come Kevin Durant poteva presentare delle complicanze sulla carta, immediatamente sopite dal fatto che si, oltre che forte sa decisamente giocare a pallacanestro, letture delle spaziature incluse. Stessa ragione per cui i vari Iguodala e Livingston sono riusciti a sguazzarvici all’interno, malgrado l’avanzare del chilometraggio percorso in carriera.
Che Wiggins potesse ricoprire il ruolo che fu di Harrison Barnes, era auspicabile per caratteristiche. Addirittura sostenute da un talento offensivo superiore. E non a caso è riuscito ad integrarsi meglio – performando in crescendo – durante tutto l’arco della stagione. Questione diametralmente opposta per Kelly Oubre Jr. (come detto in precedenza), che per background non è riuscito ad emergere completamente. Come ci suggerisce la prime delle 4 clip a seguire:
Non solo è visibile la totale confusione mentale nell’osservare l’impostazione dal palleggio di Steph, quasi in preda al panico nel cercare di capire dove nascondersi per non nuocere danni. Ma come spesso accade in circostanze analoghe, Oubre riesce ad occupare l’unica posizione dove non doveva sostare. Generando il prolungato disappunto del compagno, per un momento simbolo delle incomprensioni tra la sua visione del campo e l’inadeguatezza apparente dei compagni.
Una condizione diversa rispetto alla lettura di Wiggins nella seconda clip a seguire, anche se ci troviamo molto più avanti nella stagione.
La questione non si limita ad attendere il movimento scelto da Curry, che nella maggior parte dei casi risponde alla scelta meno prevedibile dal diretto avversario, per creare vantaggio indiretto o farsi trovar pronto negli spazi liberi. Ma conoscerne il carnet di soluzioni, tanto da accompagnarne la sorte; o addirittura agevolarla, come Green fa perfettamente. Il risultato sono 3 punti a referto.
Bazmore, nella parte alta dello schermo, dimostra contemporaneamente di saper stare dentro al gioco, offrendosi a Draymond per una potenziale alternativa, sfruttando potenzialmente la gravity che Steph genera con il suo movimento, rispetto alla difesa avversaria.
Quindi, conoscere la visione del principale terminale offensivo di squadra (in assenza di Klay, forzatamente), è la prima regola per resistere nei Warriors. E contrariamente a quello che si può pensare considerandolo il grande giocatore che è, giocare a sostegno di Curry è difficilissimo.
In questa clip esegue un inesperto Juan Toscano Anderson, che nella finta sul pick and roll sembra essere il primo a cadere, vanificando lo sforzo anche a seguire, occupando una mattonella che non gli competerebbe in un frangente di seconda chance.
Una zona di campo dove Steph è solitamente letale per differenti opzioni abbracciate, come dimostrato nell’ultima clip in esame. Da sottolineare la preziosità di Bazemore, nel proporre un “falso” gioco a due che sguarnisce la linea di fondo avversaria, dove un chirurgico Curry si inserisce rapidamente.
Cosa abbiamo imparato dalla stagione di Curry?
Stavolta si, la domanda è più retorica che mai, perché se qualcosa ci ha mostrato la stagione mostruosa di Steph è che non c’è più niente da imparare. Possiamo sforzarci di trovare difetti al giocatore, ma qualsiasi sia il lato in cui lo guardiamo, è impossibile non annoverarlo tra i migliori di sempre nel ruolo. Anche senza partire dal palmares o dai numeri, e quindi dai record battuti e quelli in procinto di essere riscritti.
Ad esempio, se vi ricordate il proverbiale “terzo quarto Warriors” degli anni d’oro, guardando alla regular season conclusa, potremmo serenamente parlare di “terzo quarto Steph”, ed i numeri fanno impressione.
Si parla di 11.4 punti di media nella frazione centrale, con 2 triple a segno su 4.7 tentativi. Dopo di lui, solo Damian Lillard, staccato di due lunghezze realizzative percentuali. Ed anche a livello di “ottimi inizi”, con 9.5 punti di media guida la speciale classifica dei primi quarti di gioco, prendendosi una pausa da 5.6 nel secondo e chiudendo le gare con 7 spaccati nell’ultimo (con poco meno di 6 minuti di impiego). Inutile dire che per medie realizzative, nessuno si avvicina al superamento della doppia cifra registrato da Curry in un terzo periodo stagionale (e nei restanti).
Che si possa azzardare l’ultimo passo di una ricostruzione (meglio sarebbe “ammodernamento”) di squadra partendo da lui, è evidente ed evidenziato da quello che abbiamo appena finito di vedere.
Almeno fino a quando Steph potrà permettersi quell’imprevedibilità di rilascio, quel range di tiro infinito, quella velocità di lettura delle difese che lo rende – con o senza palla – giocatore di movimento, dinamico ed efficace.
Oltre ad un discreto difensore di sistema, altra cosa non scontata se guardiamo alla stazza. Un preconcetto che dovrebbe essere superato a questo punto della storia, anche se periodicamente torna a fare capolino.
Nessuno griderebbe allo scandalo se venisse premiato con la statuetta di MVP, ma anche se non avverrà, c’è veramente poco da disperarsi (o tranquillizzarsi, in base dal se siamo estimatori o detrattori): con questo campionato Stephen Curry ha dimostrato definitivamente di stare tra quei giocatori che fanno categoria a sé.
Quelli che se “dovessimo premiare il più forte, vincerebbero sempre loro”. In buona compagnia con LeBron James e pochi altri, al momento. Per non dire nessun’altro.













































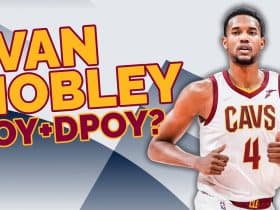



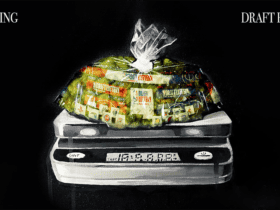












Lascia un Commento
Mostra i commenti